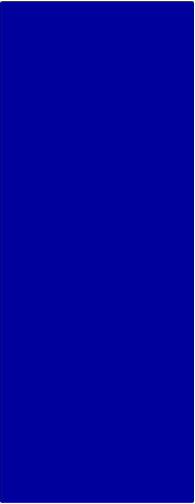
•
lo scheletro
•
i muscoli
•
che muscoli usiamo…
•
il polso
•
mano e avambraccio
•
il gomito
•
il piede
•
la spalla e la scapola
•
orecchio
•
legamenti e tendini
•
occhio vista e percezione
•
5 sensi
•
cosè la stabilità
•
mobilità articolare
•
qualità motorie
Cercherò
di
descriverti
come
funzionano
i
muscoli
del
nostro
corpo
,
la
materia
è
complessa,
in
alcuni
casi
dovrò
sorvolare su alcuni aspetti, per non annoiarti.
La
struttura
di
base
per
la
contrazione
del
muscolo
è
la
miofibrilla
(o
miofibra)
la
cui
lunghezza
varia
da
10
a
100
micron
(1
micron
=
1/1000
di
mm.).
Il
diametro
di
una
miofibrilla
è
di
circa
1
micron.
Al
microscopio
la
miofibrilla
mostra
come
componente contrattile elementare il sarcomero, costituito a sua volta dalle proteine miosina, actina, tropomiosina e troponina.
La
sommatoria
dell'azione
dei
diversi
sarcomeri
determina
la
contrazione
di
tutto
il
muscolo,
quindi
l'avvicinamento
dei
capi
estremi di inserzione e, di conseguenza, lo spostamento dei segmenti del corpo sui quali sono inseriti i tendini.
Una
fibra
muscolare
è
composta
da
circa
1000
miofibrille.
In
successione
le
fibre
si
riuniscono
prima
in
fasci
primari.
Più
fasci
primari
si
raggruppano
poi
in
fasci
secondari
e
infine,
in
fasci
terziari.
Il
tessuto
connettivale
che
avvolge
la
miofibra
viene
denominato sarcolemma.
La
diramazione
di
questo
tra
i
fasci
prende
il
nome
di
perimisio
che
a
sua
volta
diventa
epimisio
quando
avvolge
l'intero
muscolo.
Il
liquido
che
circonda
le
miofibre
e
che
contiene
anche
i
substrati
energetici
del
muscolo
viene
definito
sarcoplasma.
L'apporto
al
muscolo
di
ossigeno
e
sostanze
nutritive
viene
veicolato
dal
sangue
attraverso
un
elevatissimo
numero
di
capillari
arteriosi.
Gli
stessi
capillari,
divenuti
venosi,
con
percorso
inverso
consentono
l'eliminazione
delle
sostanze
non
più
utilizzabili
e
dell'anidride
carbonica.
L'aspetto
complessivo
del
muscolo
evidenzia
una
parte
centrale,
detto
ventre,
e
due
apici
terminali
detti
tendini.
Motoneuroni:
sono
le
centrali
che
ricevono
e
trasmettono
al
cervello i dati che consentono il movimento muscolare.
Le
fibre
muscolari
rosse:
a
contrazione
lenta
e
con
grande
resistenza
alla
fatica
hanno
inseriti
all’interno
piccoli
motoneuroni.
Le
fibre
muscolari
a
contrazione
rapida
,
hanno
maggiore
resistenza alla fatica.
Le
fibre
muscolari
bianche,
a
contrazione
rapida
e
poco
resistenti
alla
fatica
hanno
grossi
motoneuroni.
La
loro
caratteristica è di avere la possibilità di una
intensa attività ma per un tempo breve.
I
tendini,
composti
da
fibre
connettivali
riunite
in
fasci
circondati
da
tessuto
lasso,
si
inseriscono
tra
due
o
più
articolazioni.
Un
tendine
è
in
grado
di
sopportare
carichi
elevatissimi,
anche
superiori
ai
500
kg./cm2
della
sua
sezione.
Comunque,
al
contrario
di
quanto
si
immagina,
l'elasticità
del
tendine
è
inferiore di quella del muscolo e il suo stiramento non può oltrepassare il 4-5% della sua lunghezza.
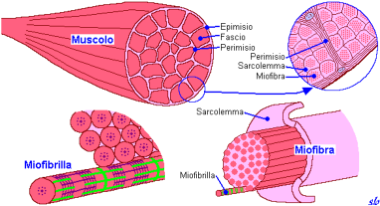
Quindi attenzione ai movimenti che fai, riscaldati prima di una seduta di allenamento o di una gara!
In
alcuni
muscoli
il
tendine
presenta
una
struttura
elicoidale
(es.
il
Gran
Pettorale).
Questa
ne
aumenta
l'elasticità
e
ne
consente
un più elevato assorbimento della tensione.
La
contrazione
muscolare
prevede
una
sequenza
di
interventi:
dal
cervello
dalle
cellule
dell'area
motoria.
Dalle
cellule
dell'area
motoria
partono
gli
impulsi
nervosi
(fino
a
circa
50
al
secondo,
ad
una
velocità
da
12
a
120
metri
al
secondo)
diretti
alle
corna
anteriori
del
midollo
spinale
(motoneuroni
alfa).
Questi
proseguono
poi
fino
alla
placca
motrice
che
è
posta
a
contatto
delle
fibre
muscolari
interessate.
In
relazione
alle
caratteristiche
motorie
a
cui
sono
deputati
i
muscoli,
movimenti
fini
e
delicati
come
quelli
delle
mani,
oppure
movimenti
di
locomozione,
una
placca
motrice
può
contrarre
un
ridotto
numero
di
fibre
(da
5
a
10)
oppure
molte
fibre
contemporaneamente
(fino
a
150
e
oltre).
All'arrivo
dello
stimolo
nervoso
la
placca
motrice
libera
acetilcolina.
Quindi
l'impulso
da
nervoso
si
trasforma
in
biochimico
e
l'acetilcolina
va
a
fissarsi
su
specifici
ricettori
posti
sulla
membrana
della
fibra
muscolare
e
la
depolarizza
(ne
annulla
il
potenziale
elettrochimico).Una
volta
depolarizzata,
la
membrana
cellulare
può
essere
attraversata
dagli
ioni
sodio
che
penetrano
dentro
di
essa
mentre
fuoriescono
gli
ioni
potassio.
Questo
porta
ad
una
inversione
di
polarità
elettrica, ora la fibra è elettropositiva all'interno ed elettronegativa all'esterno.
Il
potenziale
di
azione
che
si
è
creato
è
maggiore
del
potenziale
di
soglia
(il
limite
necessario
per
agire)
di
eccitazione
della
fibra
muscolare.
Pertanto
si
propaga
dalla
fibra
nervosa
a
quella
muscolare.
Il
potenziale
di
azione
depolarizza
i
tubuli
trasversi
del
reticolo
sarco-plasmatico
che
sono
indotti
a
liberare
ioni
calcio.
Il
legame tra ioni calcio, troponina e tropomiosina fa si che miosina e actina interagiscano scorrendo l'una dentro l'altra, ovvero contraendo il muscolo.
In
sostanza
gli
ioni
calcio
interrompono
momentaneamente
il
meccanismo
di
decontrazione
muscolare
per
cui
alla
miosina
viene
impedito
di
agire
sull'actina
per
mezzo dell'ATP (Adenosin-trifosfato).
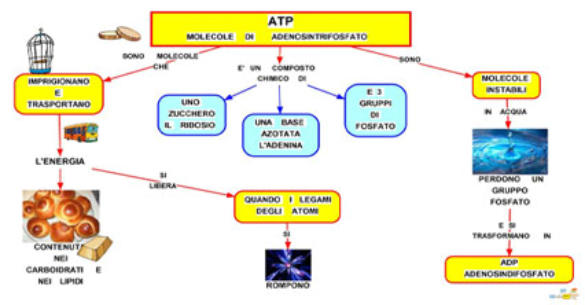
L'energia
per
la
contrazione
muscolare
viene
fornita
dall'ATP
(Adenosin-trifosfato)
che
si
scinde
in
ADP
(Adenosin-difosfato)
e
P
(fosfato
inorganico).
L'ATP
presente
nei
muscoli
è
molto
limitato
per
cui
è
necessario
ricostituirlo
in
continuazione.
La
resintesi
dell'ATP
avviene
attraverso
tre
diversi
meccanismi,
ognuno
legato alla durata e all'intensità dell'impegno muscolare.
Il muscolo può utilizzare tutti e tre i sistemi contemporaneamente oppure privilegiarne maggiormente uno rispetto altri due:
Sistema
aerobico
:
le
tensioni
muscolari
sviluppate
sono
molto
basse
(sotto
il
30%
circa
del
massimale).
Durante
il
lavoro
muscolare
il
consumo
e
il
reintegro
energetico
rimangono
in
equilibrio,
permettendo
una
durata
che
oltrepassa
i
3
minuti
per
arrivare
anche
ad
alcune
ore.
I
substrati
energetici
sono
forniti
inizialmente
dall'ossidazione
dei
glicidi
poi,
dopo
30-40
minuti
circa,
essenzialmente
dai
grassi.
Il
prodotto
finale
di
questa
reazione
energetica
è
l'acqua,
l'anidride carbonica e l'energia che risintetizza l'ATP. L'acqua e l'anidride carbonica vengono eliminate con la respirazione, i reni (urina) e la sudorazione.
Sistema
anaerobico
alattacido
:
le
tensioni
muscolari
sono
molto
elevate
(submassimali
e
massimali)
e
il
lavoro
muscolare
intenso
può
essere
protratto
solo
per
circa
8-10
secondi.
L'energia
spesa
viene
ripristinata
dopo
circa
3
minuti.
Questo
sistema
dipende
dagli
accumulatori
di
energia
CP
(creatinfosfato)
e
non
necessita
di
ossigeno.
L'ATP,
grazie
all'enzima
ATPasi
si
scinde
in
ADP
e
perde
P
(radicale
fosforico
ad
alta
energia)
che
determina
la
contrazione.
Subito
dopo
L'ATP
viene
risintetizzato
grazie
alla
cessione
di
P
da
parte
della
CP
(fosfocreatina).
Oltre
gli
8-10
secondi
di
massima
tensione
muscolare,
la
fosfocreatina
tende
a
esaurirsi
e
non
riesce
più
a
fornire
il
fosfato
utile
alla
resintesi
dell'ATP.
Se
si
vuole
proseguire
nel
lavoro,
ovviamente
con
tensioni
muscolari
meno
intense,
si
è
costretti ad utilizzare un altro meccanismo energetico, quello anaerobico-lattacido.
Sistema
anaerobico-lattacido
:
le
tensioni
muscolari
sono
mediamente
elevate
e
possono
essere
protratte
fino
a
circa
45
secondi.
Dopo
lo
sforzo
la
capacità
contrattile
iniziale
viene
ripristinata
dopo
circa
tre
ore,
tempo
di
smaltimento
dell'acido
lattico
(la
metà
ogni
15
minuti
circa.
Negli
atleti
specialisti
può
scendere
anche
sotto
gli
8
minuti).
La
reazione
biochimica
parte
dalla
fosforilazione
del
glicogeno
(formazione
di
ATP)
ad
opera
dell'energia
fornita
dall'ATP
durante
la
contrazione.
Questa
reazione
biochimica
porta
alla
formazione
di
glucosio-1-fosfato
che,
per
mezzo
dell'enzima
fosfoglicomutasi,
permette
la
formazione
di
glucosio-6-fosfato.
Seguono
poi
altre
reazioni
complesse
che
terminano
il
ciclo
con
la
formazione
di
acido
piruvico
e
acido
lattico.
La
presenza
di
acido
lattico
limita fortemente la capacità di proseguire nel lavoro. Anche questo meccanismo avviene in assenza di ossigeno.
riposatevi so che non è semplice, Buon tiro...
SIAMO COSI’
muscoli - siamo così
Fontana Alessandro - Allenatore e Docente incaricato FITARCO




























